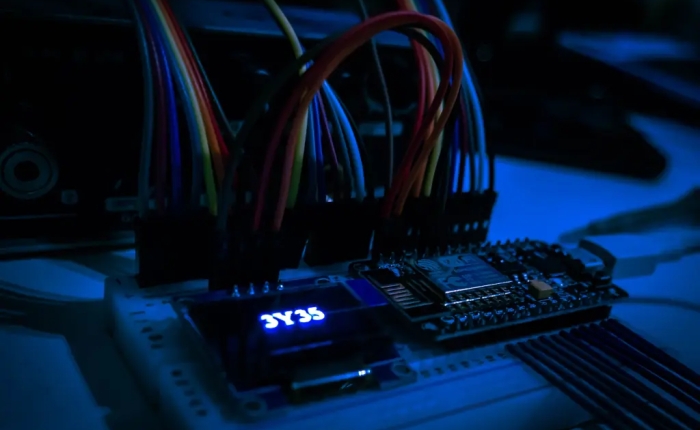«It’s all to much for me to see
A love that’s shining all around here
The more I am, the less I know
And what I do is all too much»
(The Beatles, It’s All Too Much, 1967)
Ero in un palazzo grandissimo, a tre piani, una sorta di albergo, anzi un albergo lussuoso. Una scala a spirale rivelava le vertigini di uno strano timore: perché mi sentivo così strano? Eppure poche volte nella vita avevo visto un posto così signorile e così elegante. Un led luminoso attaccato alla parete rivelava gli eventi del giorno: al primo piano si teneva il concerto di Gigione e Jo Donatello, due cantanti neomelodici molto famosi nelle zone nostre. Argomenti sessuali o religiosi in canzonette triviali e geniali nella loro ignoranza. Entro nella sala cinema del primo piano, gremita fino all’orlo: una parte della folla era seduta, ma la maggioranza era in piedi a fischiare e schiamazzare. Gigione e Jo Donatello si esibivano cantando un’ode a Santa Rita, che mi stava facendo ridere: stavo dimenticando per qualche attimo le vertigini del mio strano timore. Siccome Gigione voleva esprimere un senso di tragicità e di pathos per poter cantare degnamente il senso del divino, ora chiamava a supporto sul palco una figura in nero, un’eminenza oscura, dai lunghi capelli neri e gli occhiali da sole. Questa losca figura si faceva strada in mezzo alla folla impugnando una croce rovesciata. Oh, ma chi è? Mi sembra di conoscerlo. Quello è Ozzy Osbourne. Gigione spiegava alla folla che voleva un neomelodico a supporto, qualcuno che avesse la voce simile a quelli che a Pasqua, sui carri e sui furgoncini, cantavano le lodi della Madonna dell’Arco nei pressi di Napoli. E proprio questo musicista gli sembrava eccellere nello stile del canto religioso lamentoso e popolare tipico dei fedeli della Madonna dell’Arco. Ozzy stava cominciando a intonare a cappella una canzone dei Black Sabbath, forse N.I.B o Electric Funeral. Quando è bravo questo cantante: ascoltate quanto è sentimentale e quanto è religioso, cari amici, diceva Gigione, che, non capendo le sue parole, pensava volesse intessere le lodi alla Vergine.
Il concerto si interrompeva. Scendi dal palco, Gigione, vai via, diceva la folla. Anche tu, pagliaccio con la croce rovesciata, vai via. Un losco individuo, che si era annunciato come imprenditore e filantropo, si avvicinava al palco e indicava con un dito lo schermo in fondo: guardate qui l’ immagine della Madonna di P., esiste e l’ho filmata. Forza, gente, facciamo una colletta per la festa della Madonna di domani.
L’imprenditore, poi, era sceso tra la folla in delirio: la gente, con alcuni coltelli, cominciava a tagliarsi sulle braccia e le guardie, con delle vaschette, si avvicinavano per raccogliere il sangue. Alcuni medici in una lunga tunica bianca, come sacerdoti del male passavano nella folla per medicare le ferite. Un fremito mi assale, ma non sembro impressionato dalla crudezza di quella scena.
La Madonna proiettata sullo schermo era Iside trionfante, dalla tunica cristallina, con un iPhone in mano, mentre si faceva un selfie. Applausi, applausi intermittenti e poi ripetuti in un boato. La folla cominciava a urlare e strepitare. Io non riuscivo più a staccare gli occhi dallo schermo: non me ne sarei andato per nessuna ragione al mondo.
Io non me ne ero manco accorto, ma il mio amico James Valentino era lì accanto a me, mi fissava e mi tirava per un braccio. Faccio per salutarlo, ma lui mi strattona ancora più forte.
– Questi so’ mariuoli, andiamocene. Ci vogliono far credere alle favole. Come può un uomo di scienza come te credere a queste cose?
Gigione, intanto, era sceso tra la folla. Veniva proprio verso James Valentino, l’unico perplesso in quella folla strepitante, e si avvicinava incuriosito a lui.
– Caro, sei l’unico che non applaude? Non credi alla Madonna? Te ne vuoi andare?
James non ha risposto.
– Che fate, Ve ne andate?
Gigione sporgeva il capo verso di lui per vedere se stava bene.
– Caro signor Gigione, io non me ne andrei, ma James non sopporta la religione. Penso che ce ne andiamo.
– Sei un bravo ragazzo a differenza di questo qui – mi ha detto Gigione – Cercate di rimanere. Dopo canto di nuovo.
L’immagine della Madonna, intanto, sfumava tra le onde cristalline della mia visione. Il grande schermo rivelava una pubblicità: rimanete con noi, cari telespettatori. Nella villa presentazioni di libri, eventi culturali, musica e serie TV. Rimanete con noi.
– Hai visto, James? – gli ho detto – James, possiamo pubblicizzare i nostri libri. Hai capito?
James Valentino era frastornato: i suoi occhi cerulei si stavano trasformando in un arcobaleno di luci oscure, un tripudio all’insofferenza verso la vita. Quella vita.
– James, non fare così. Ce ne andiamo se non vuoi rimanere.
Nella folla siamo stati strattonati a destra e a manca, poi ci siamo avviciniati verso l’uscita. Dei bodyguard, con la divisa dei carabinieri, ci hanno sbarrato l’ingresso.
– Possiamo uscire? – ho la voce tremante.
– Motivi di salute, lavoro o necessità? – hanno chiesto i bodyguard, indispettiti.
Ehm, voglio inventare una scusa. Ma quale scusa? In fondo è verità.
– Salute, il mio amico non si sente bene. Il mio amico è pallido.
– È stato contagiato dal virus? L’ha fatto il tampone?
– Sì, è negativo.
– Allora, aspettate. Chiamo l’ambulanza.
James stava per andare su tutte le furie, non voleva attenzioni e mi strattonava di nuovo per un braccio.
– Si figuri, lasci stare, agente. Tra poco starà meglio.
Intanto Gigione si stava avvicinando al palco, facendosi strada tra la folla, con un microfono in mano.
– Forza ragazzi, tutti a cantare in coro, o coso nun s’aiza, e mo comm aggia fa!
Uno dei carabinieri lo strattonava. Gigione ha lanciato un gemito nervoso.
– Oh, guagliò, mo è il turno nostro, no?
– No!
Un altro carabiniere gli ha detto:
– Ora basta con l’arte e la musica. Le visioni religiose non sono finite. Tra mezz’ora poi c’è il telegiornale. Se volete aspettare il vostro turno per esibirvi, voi artisti potete accamparvi sul pavimento.
Il carabiniere ha indicato alcune piattaforme rialzate che fanno da contorno alla sala. Altri artisti, musicisti, opinionisti e blogger attendevano il loro turno, seduti a terra, su asciugamani d’oro e di perle.
Un varco si è aperto tra la folla e io ho indicato a James la piattaforma con tutti gli artisti.
– Ti piacerebbe finire lì, tra quelli lì? – gli ho domandato con euforia.
– In mezzo a quei cialtroni? No. Preferisco non essere chiamato artista.
– Perché non modifichi il tuo libro, lo rendi più commerciale e provi la scalata al successo?
– Ci vogliono i soldi per pubblicizzarlo. Tu ce l’hai?
– No
– E neanche io. E poi mi direbbero di cambiare il libro per venderlo, e io non voglio.
– Vabbè, andiamo su, al secondo piano.
I carabinieri fermi all’ingresso mi hanno ascoltato, hanno aperto la porta e ora ci scortavano verso il secondo piano. Ancora quella scala a forma di spirale, ornata di tappeti e di pietre preziose. Mentre salivo, uno sguardo verso la tromba delle scale: le vertigini, ora più consistenti, fremevano attraverso il midollo spinale e diventavano spine nella rosa del mio racconto. Volevo uscire: l’atmosfera di questo palazzo, per quanto lussuoso, stava spegnendo le mie forze e stava annientando il mio respiro. Come sarebbe bello uscire. Ma vedo che qui nessuno vuole uscire. Tutti sono felici di rimanere qui, a quanto pare. Se dico agli altri che voglio uscire, mi daranno del pazzo.
Il secondo piano: una lussuosa hall con un grande bancone dove si servivano liquori di ogni tipo, ma principalmente caffè ed energy drink. Il vociare fitto di quegli spettri quasi inconsistenti, seduti ai tavolini, opportunamente distanziati l’uno dall’altro, era così pungente che la mia mente era punta da corde prima intermittenti, poi sempre più tese.
– Mi fa male la testa, James, il mio sistema nervoso centrale non risponde bene, la tensione disfa la parallasse del mio fine sentire.
– Non ti capisco, M. Ma stai parlando in codice?
– Perché?
– Caro M., dici sempre troppe parole che non portano a nulla, invece dovresti imparare a tacere ogni tanto.
Attraverso il bancone la suadente voce di una ragazza all’improvviso si spegneva e, con un accento a me familiare, strideva un acuto vibrato.
– Accattatevi i biglietti ra lotteria. Domani abbìa n’ata vot u campionato. Iucatevi a bulletta.
Intanto alcuni operai, vestiti con tute da lavoro, si avvicinavano al bancone, reclamando di voler giocare la schedina. Alcuni schermi appoggiati al di sopra del bancone trasmettevano immagini porno: gli operai fissavano gli schermi, mentre bevevano, estraniati dal mondo.
Alcuni giovani, una decina circa, i cui volti erano nascosti da mascherine nere, passeggiavano nel corridoio, sfoggiando le loro camicie bianche: si passavano spesso le mani sulla testa per aggiustare i capelli rasati ai lati e ogni tanto agitavano le loro collane di falso oro per mostrarle alle ragazze sedute ai tavolini. Ai loro polsi ho scorto un braccialetto di metallo fosforescente: James mi faceva notare che quello il pass per entrare nelle aree di lavoro come operai. Ho guardato quei volti oscuri e di poche parole con molta curiosità. I ragazzi sono appoggiati a una ringhiera di vetro, che apriva un baratro al centro del piano. Appoggiati al baratro, i ragazzi incrociavano le gambe, rivestite da pantaloni aderenti, forse di velluto, molto stretti alle caviglie. Fissavano due o tre ragazze sedute ai tavolini di fronte, che erano attaccate ai loro dispositivi per farsi delle foto in pose strane: occhi chiusi e la lingua di fuori. Le femmine raramente davano un’occhiata ai maschi, ridendo, forse prendendoli in giro o forse imbarazzate. Uno dei ragazzi mostrò una ferita alla mano, che ancora grondava di sangue; forse una ferita riportata sul lavoro. O forse si era tagliato di proposito, come la gente che aveva offerto il suo sangue alla Madonna di P. nella sala cinema del primo piano. Una delle ragazze, guardandolo, si leccò le labbra in un impeto di erotica approvazione. Nessuno accennava a una parola, nessuno accennava un contatto, nessuno osava accennare a rompere la struttura di quel rituale.
– James, perché quel tipo mostra tutto quel sangue alla ragazza? – ho chiesto al mio maestro.
– È una forma di corteggiamento, caro M. In questo palazzo non ci sono soldi ma c’è solo sangue. Il sangue funziona come merce di scambio, proprio come il denaro. Forse quel tipo vuole fare vedere alla giovane di essere il più ricco e il più potente dei suoi compagni.
– Mah… questi … questi sono pazzi – ho accennato nello spasmo della nausea, che in crescendo si diffondeva dallo stomaco allo stridio dei miei nervi.
A un tratto uno dei ragazzi appoggiati alla ringhiera diceva ai compagni di fare presto perché avevano finito il turno di lavoro da troppo tempo: dovevano presentarsi giù alla sala cinema in tempo per il telegiornale.
– Ma, scusa, James? Loro possono uscire da qui? Gli operai dico?
– No, caro. Se non hanno il virus, devono rimanere qui.
– Ma dove lavorano?
– C’è un padiglione poco più avanti. Ogni mattina si svegliano, escono dal dormitorio del terzo piano e vanno a lavoro. Poi di sera escono, vanno in sala cinema e a una certa ora tornano a dormire.
– Mah, che bella vita. Quindi al terzo piano ci sono i dormitori?
– E non solo.
– Come, non solo?
James si è stretto nelle spalle.
– Perché vuoi saperlo, M.? Perché sei così masochista?
Io pregavo James di mostrarmi il terzo piano, ma lui era riluttante. Forse voleva proteggermi da un segreto che avrebbe potuto annientarmi. O forse quel segreto avrebbe potuto darmi troppa euforia da spegnere la mia voglia di fargli altre domande. Eh sì, perché, secondo me, James non lo ammetteva, ma gli piaceva farmi da maestro e darmi spiegazioni.
Abbiamo salito l’ultima rampa di scale che conduceva al terzo piano.
Urla, stridii, schiamazzi, suoni e voci prima lievi, poi rauche mi rivelavano contraddizioni di colori e di suoni, che da un lato mi ripugnavano, dall’altro mi attraevano. Quella musica così dissonante rodeva così tanto la mia coscienza che non potevo smettere di ascoltarla. Ah povero me. Un lungo corridoio con porte tutte uguali sulla sinistra e finestre tutte uguali sulla destra. Alcune figure vestite di bianco, i medici, passavano con passo inquieto e felpato verso di noi. Erano rivestiti da capo a piedi di una tuta bianca e avevano un elmetto con una visiera trasparente. Avevano delle siringhe in mano con aghi spuntati. Attraverso la vetrata dei loro sguardi un sorriso stampato sul volto. Più guardavo quel sorriso e più mi sembrava un ghigno spaventoso. Un led luminoso fendeva il soffitto e le pareti: attenzione, pericolo contagio.
– Ecco, tu mi hai chiesto che cosa c’è al terzo piano. Ecco cosa c’è.
– Ma… Ma… Allora i malati li tengono qui?
– Ah sì, ora l’hai scoperto?
I medici ci fissavano e ci intimavano di indossare le mascherine. Ci hanno chiesto come abbiamo evitato i controlli e dov’era la nostra cartella clinica. Ma non eravamo malati. James glielo ha detto. Non siamo malati. Siamo giornalisti e vogliamo testare le loro cure miracolose.
– Non si potrebbe, ma per voi faccio un’eccezione. Siete giovani e dovete capire che la profilassi è importante per evitare il virus. Stanza numero tre, seguitemi, prego.
Alcuni carabinieri sono usciti da non so dove e ora ci scortavano verso un piccolo ingresso: una porta verde con un pomo a forma di banana. Hanno inserito una scheda in un lettore LED accanto alla porta: i raggi laser a guardia dell’ingresso si sono attenuati e la porta si è aperta.
Un’altra sala cinema, ma più piccola, con un altro schermo imponente e un’altra calca: stavolta però ogni individuo era seduto a terra, contenuto da una campana di plexiglas pressurizzata. Non potevano comunicare con nessuno se non attraverso il permesso delle guardie, che aprivano i loro microfoni, se lo ritenevano opportuno, e li facevano comunicare con le altre campane. Distanziamento sociale. James mi spiegava che tutte le conversazioni venivano registrate e tenute in archivio, nel caso i pazienti avessero infranto la legge con i loro discorsi.
– Ah sì, e la privacy?
Una guardia ha sentito la mia domanda e si è avvicinata a me.
– Lei ha forse qualcosa da nascondere che non possiamo sentire?
– No, no, per carità, agente.
Speravo di allontanare la guardia con queste parole. James mi ha indicato la scena con un dito:
– Ecco, qui i pazienti trascorrono la quarantena nel distanziamento sociale più assoluto.
– Ma è terribile. E lo schermo del cinema in fondo alla sala che cosa proietta?
– Quello non è uno schermo, ma è un rivelatore di paure. A turno, ogni persona in quarantena si avvicina allo schermo. I dottori gli infilano elettrodi sul capo e lo schermo, senza esitazione, proietta le sue paure inconsce, che si materializzano come per magia.
Io rimango fermo: la bocca mi si era serrata in in terrore mortale. Provavo a digrignare la mascella e tutto d’un tratto la bocca mi si serrava in un trisma e in uno spasmo muscolare. Un grido di dolore.
– aaah
– Tieni la bocca aperta e lo spasmo va via – Mi ha detto James.
– Voglio provarlo
– Ma che dici? Lascia perdere, M. Tu sei troppo sensibile.
– Voglio provarlo.
– Sempre il solito fatto. Sempre il solito masochista.
Mi sono avvicinato al palco che ospitava il grande schermo. Il dottore che ci ha incontrati nel corridoio mi ha sbarrato il passo, e avvicinando un macchinario con degli elettrodi mi ha detto:
– Bene, ora le infiliamo questi e potrà così trasmettere le sue paure sullo schermo. Le diamo anche un sacchetto nel caso dovesse vomitare.
Io mi siedo su una sedia e aspetto. Lo schermo è nero, poi alcune spirali e alcuni vortici danno inizio alla trasmissione.
– Nel frattempo le inietterò un calmante per evitarle reazioni ben peggiori.
Sono molto vicino allo schermo e intanto lo schermo diventa trasparente: onde del mare che quasi riesco a toccare. Nella loro trasparenza si rifrangono al tocco delicato della mia mente.
Ecco subito l’immagine di un pipistrello, che appollaiato su un ramo a testa in giù ha la faccia di un cane. Apre la bocca e si lecca i baffi a destra e sinistra, senza mai fermarsi. Qualcuno avvicina una mano per accarezzarlo. Una mano? E’ la mia mano: le immagini seguono il mio punto di vista e lo sguardo del mio campo visivo. Il pipistrello mi morde, assatanato come il diavolo in persona, mostrando i suoi denti aguzzi da creatura dei più profondi inferi. Aaaah. Un’ovazione in sala: quelli in prima fila applaudivano e fischiavano, mentre altri, forse quelli in ultima fila, urlavano e si dimenavano. Poi subito dopo l’immagine di un cane a due teste: un dottore avvicina una scodella piena di latte e i cani cominciano a bere. Spunta di nuovo la mia mano, già sanguinante per la ferita inflitta dal pipistrello. Io faccio per accarezzarli, ma si avvinghiano al mio tocco e mi spellano quasi a morte. E poi, oddio, poi che vedo! Una scodella con teste crude di topi morti, sgozzati, e io riconosco di nuovo la mia mano sanguinante. Con un cucchiaio le prendo. Io con un cucchiaio prendo le teste mozze dei topi e le avvicino sempre di più all’obiettivo della telecamera. Aaaaah, nausea, spasmi, contratture muscolari. Mi accascio e vomito, ma il dottore mi dà uno schiaffo. Nel sacchetto, nel sacchetto. Prendo il sacchetto e vomito. Vorrei chiudere gli occhi, ma non ci riesco: qualcosa me lo impedisce, ma che cosa? Poi basta, poi gli dico basta.
– Me ne voglio andare, fatemi uscire, fatemi uscire!
Mi divincolo e loro con una siringa mi iniettano qualcosa, e poi ah, visione annebbiata: gli archi e e gli ostinati stridii alle tempie si attenuano, poi si spengono in un accordo legato, più tenue e sottile, sempre più lieve. Il dottore mi ha sfilato gli elettrodi.
– Mah, la sua reazione alle sue paure è un po’ troppo anormale. Forse ha contratto il virus. Dobbiamo tenerla qui per qualche accertamento.
– Qui? Accertamento? No, no, voglio uscire.
– Glielo spieghi lei, signor…
– Valentino – lo ha preceduto James, che si è subito avvicinato a me con passo felpato.
Quelli che stavano in ultima fila, mi ha spiegato James, erano i pazienti più gravi, che non accettavano di vedere scene forti e non si rassegnavano davanti alle loro paure. Poi c’erano quelli tenuti in osservazione, che erano a volte terrorizzati e a volte no, e quelli trattati con i farmaci, in via di guarigione, che amavano le immagini più violente e ripugnanti.
– Ma tu non le ami quelle immagini, vero James?
– No, ma non le disprezzo. Mi sono indifferenti.
Proprio mentre stavamo affrontando il discorso, si è sentita una sirena in lontananza, prima intermittente, poi sempre più veloce e più veloce. Pericolo, pericolo. Evacuazione. Una voce metallica diffusa attraverso gli altoparlanti della sala cinema. I medici correvano su e giù, di qua e di là per la stanza. Le guardie armate cercavano di mantenere la calma e di fermare i pazienti che, seppure sotto le campane di plexiglas, battevano colpi e chiedevano di uscire.
– Ma che succede? Che succede? – ho chiesto a James, terrorizzato.
– È in atto il meccanismo di autodistruzione dell’edificio. Ogni tanto le macchine, i computer e i dispositivi si surriscaldano troppo e rischiano di bruciare vivi gli abitanti di questo posto, che non riescono ormai a vivere senza. Il meccanismo di autodistruzione misura la temperatura dell’edificio e, se è troppo alta, innesca un conto alla rovescia. Se gli scienziati, dal loro pannello di controllo, non riescono ad abbassare in tempo la temperatura dei dispositivi e dei computer, il meccanismo fa esplodere delle testate atomiche per evitare agli abitanti una morte lenta e dolorosa a causa dei loro tanto amati dispositivi.
– Ma che stai dicendo? E dove scappano tutti?
– La gente, presa dal panico, prova a scappare, ma è inutile.
– Perché è inutile?
– Non puoi scappare. Le guardie rimangono sempre ai loro posti di blocco attorno all’edificio, anche quando l’allarme è attivo: questa è la terza volta in un mese. Chissà dove andremo a finire di questo passo.
– E allora basta, è meglio che moriamo anche noi. Deve esplodere questo posto di…
James mi ha trattenuto la bocca e mi ha strozzato le parole in gola. Dovevo stare zitto. Zitto, altrimenti se qualcuno mi sentiva poteva pensare fossi infetto ma asintomatico.
Alcuni amici di James, degli operai del secondo piano, si avvicinavano a noi: ci hanno visto passare e ci vogliono denunciare all’autorità giudiziaria per aver violato le norme di sicurezza. Ma ora erano in panico anche loro. Ci hanno preso per un braccio: ci volevano portare via di lì con loro. Ma dove?
– Toglietemi le mani di dosso, spioni – gli ho urlato io.
James ha preso uno di loro per un braccio. Forse c’era un modo per salvarsi: c’era un varco in fondo al corridoio che era usato in passato per avere rifornimenti dall’esterno. Si poteva accedere solo con una scheda di emergenza che lui aveva rubato una volta a un colonnello con l’inganno.
– Correte a salvarvi, io rimango qui.
Io pietrificato dal suo sguardo atono.
– Ma come, rimani qui? Rimani qui?
– Caro M., a differenza tua, ho smesso di credere al mito della libertà.
Gli operai mi strattonavano, mi mettevano una mano sulla bocca e mi portavano via con loro verso l’uscita di emergenza. Un lungo corridoio con alcuni varchi che sembravano nascondere una pellicola fatta di uno strano fluido rosa. Ogni volta che passavamo attraverso quei varchi, ah, ustioni, fiamme e fuoco che stridevano e avvampavano nei miei occhi. Gli operai mi tenevano per due braccia, pensando che io volessi scappare verso James Valentino. Ma io urlavo, urlavo e mi dimenavo, mi dimenavo e poi in fondo al corridoio le tenebre mi avvolgevano in un ghigno che mi richiudevano come in una bara.
Riemergo, spunto, singhiozzo e tossisco. Le immagini del mondo, prima sfocate e poi sempre più trasparenti e nitide, come il fruscio delle onde del mare. Ed ecco di nuovo la hall del palazzo, luminosa, invasa da suoni ossessivi: marcette militari, non so se nello stile della raeggeton o della trap. Suoni, che per quanto triviali mi sembravano la più geniale delle sinfonie. Ero sdraiato su una panchina nella hall, proprio sotto le scalinate a forma di spirale. Guardavo di fronte a me l’ingresso maestoso, fatto di vetri e specchi, che per quanto consunti stavano diventando iridescenti.
Una folla ballava e cantava, fusa in cerchio, accanto a me. Mi sono alzato barcollando e mi sono fatto strada tra la folla: ed ecco che il professore T., il mio professore di italiano e latino al liceo, si contorceva e si divincolava su se stesso come un folletto al centro della folla.
– Ma che sta succedendo? Che sta succedendo? – Chiedo a qualcuno.
– È lui! È lui il nostro Salvatore. Con il suo ingegno ci ha salvato la vita. Ha disinnescato il meccanismo di autodistruzione. Ora siamo salvi per sempre. Ehi, non sei contento di vivere senza più paura della morte?
Marco Di Caprio